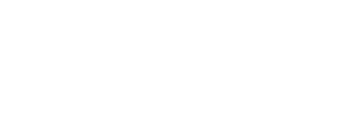Conferenza del 4 ottobre 2002
- Dettagli
- Categoria: San Mattia
- Pubblicato Mercoledì, 30 Novembre -0001 01:00
- Scritto da Super User
- Visite: 2635
PSICOANALISI E RELIGIONE
4 ottobre 2002
Per introdurre queste mie brevi considerazioni sul tema dei rapporti fra la psicoanalisi e 1a religione vorrei prendere lo spunto proprio dall'immagine che don Mario Pio ha riprodotto sulla locandina che pubblicizza questo nostro incontro. Come si può vedere, a fianco dell'immagine che ritrae Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi, don Mario Pio ha posto la raffigurazione di una Madonna con in braccio suo figlio Gesù bambino.
Così, anche se casualmente, l'immagine religiosa scelta da don Mario Pio rappresenta proprio quella "diade" madre-bambino di cui proprio la psicoanalisi ha stabilito, a livello scientifico, l'importanza per lo sviluppo psichico futuro dell'individuo. Oggi, proprio grazie alla psicoanalisi, sappiamo che quelle relazioni precoci che il bambino piccolo instaura con la propria madre sono fondamentali per il suo futuro. Se quelle relazioni saranno state positive e soddisfacenti l'individuo maturerà in futuro con un senso di fiducia e di sicurezza interiore. Ma se, al contrario, saranno state caratterizzate dal dolore e dalla frustrazione o, peggio ancora, dall'abbandono, quel bambino, da adulto, andrà incontro a seri problemi. Si produrrà cioè in lui quella ferita che rappresenta il "trauma" su cui potrà instaurarsi la sua futura nevrosi.
Ma ritorniamo ora al tema dei rapporti tra psicoanalisi e religione di cui ci siamo prefissi di parlare oggi.
In linea generale e preliminarmente vorremmo poter affermare che, prima ancora della psicoanalisi a livello scientifico, la religione ha colto ad un livello diverso ma altrettanto importante, la fondamentale importanza dei legami affettivi familiari per la storia dell'individuo.
Le storie della Bibbia possono essere esemplari al riguardo: esse raccontano di conflitti tra fratelli (Caino e Abele), di atti di disobbedienza verso il padre ripagati dal perdono (per esempio la parabola del figliol prodigo) o, al contrario, di devozione filiale ecc.
Ma prima di proseguire il nostro discorso sarà opportuno fugare un grosso dubbio che potrebbe sorgere al riguardo: nello studiare la religione la psicoanalisi si astiene totalmente (e non potrebbe essere altrimenti) dall'entrare in merito a problemi che non le competono come la dimostrazione dell'esistenza di Dio, il valore di verità che i precetti religiosi possiedono, eccetera. Non è questo il suo compito, non potrebbe esserlo, non deve esserlo.
Ma poiché la psicoanalisi è una disciplina che studia l'essere umano, l'uomo nella sua interezza ed in tutte le sue manifestazioni, essa non può, anche se lo volesse, prescindere dallo studio del vissuto religioso presente in ogni essere umano, anche il più deciso ateo che, pur nel peggiore dei casi, crede pur sempre in qualcosa, fosse anche una fede politica o la particolare dedizione ad una determinata causa che può andare dal recupero sociale dei delinquenti alla protezione degli animali o dell'ambiente.
Tuttavia non si deve pensare, ed anche questo va detto subito e chiaramente, che il rapporto tra psicoanalisi e religione sia stato da subito idilliaco o, come si dice popolarmente, "rose e fiori". Al contrario la psicoanalisi e la religione sono spesso entrate in aperto conflitto.
Freud, il fondatore della psicoanalisi, era ateo. Non che lo fosse sempre stato: di origini ebraiche, anzi, aveva ricevuto un'educazione religiosa puntigliosa e meticolosa come spesso sanno darla solo certi educatori religiosi ebrei.
Jung, che per un certo periodo fu allievo di Freud anche se poi se ne distaccò, era addirittura figlio di un pastore protestante.
Ma come era frequente negli uomini di scienza del secolo scorso e, talvolta, fino ai nostri giorni, la religione, con il suo bagaglio di verità rivelate, era spesso percepita da questi come un ostacolo alla ricerca di nuove verità: basti fra tutti citare qui il caso di Galileo Galilei che dovette pagare di persona per il fatto che le sue teorie sulla rotazione della terra, che oggi sono universalmente accettate, contraddicevano quanto era scritto in alcuni punti delle Sacre Scritture.
Evidentemente erano ancora lontani i tempi in cui la stessa Chiesa si sarebbe sforzata di spingere i fedeli a non fermarsi al senso letterale delle sacre scritture ma ad andare al di là di questo per coglierne il senso profondo.
In questa modificazione del modo di porsi di fronte alle sacre scritture molti degli steccati che in passato hanno tenuto separato il mondo della scienza da quello della religione sono venuti a cadere. Ma, per quel che riguarda più specificatamente il rapporto tra la religione e la psicoanalisi, in questo modo di porsi di fronte alle sacre scritture che, proprio perché non devono essere intese nel loro senso letterale, necessitano di un lavoro di interpretazione teologica, la religione e la psicoanalisi si trovano a percorrere una strada per molti versi simile.
In realtà anche la psicoanalisi come metodo scientifico si è sempre posta in una condizione che la spinge ad andare al di là del senso letterale delle cose, che va alla ricerca di significati nascosti, che non si ferma sulle apparenze. Appunto nella ricerca di senso e di significato della vita la psicoanalisi e la religione possono sentirsi preziose alleate. Addirittura, sempre per quel che riguarda più specificatamente l'interpretazione delle sacre scritture, non sono mancati neanche esempi di collaborazione proficua, di teologi cioè che si sono serviti della psicoanalisi per penetrare nel senso più profondo delle Sacre Scritture e, viceversa, di psicoanalisti che fanno ricorso alla teologia per comprendere molti dei simbolismi che le fantasie ed i sogni dei loro pazienti possono presentare.
Le collaborazioni, o se preferite, le sinergie tra psicoanalisi e religione sono cominciate all'inizio della comparsa dei primi professionisti che si sono dedicati a questa disciplina. In questa prima fase la religione, o, più precisamente, la rigidità che talvolta poteva trapelare da certe sue regole morali, veniva studiata prevalentemente nel suo aspetto patogeno. Naturalmente in questo campo non sono mancati i conflitti aperti i cui strascichi, talvolta, perdurano ancora oggi.
Una teoria molto accreditata della psicoanalisi sostiene, infatti, che alla base di alcuni profondi disturbi psicologici ci possono essere dei "sensi di colpa" non risolti. Il "senso di colpa" è, come si suol dire, una "brutta bestia". Si può sfuggire ad una punizione che ci viene dall'esterno (dicendo una bugia per non farci scoprire, per esempio, oppure sottraendoci a certe nostre responsabilità o in mille altri modi ancora) ma è praticamente impossibile evitare una punizione che proviene dal nostro stesso inconscio, che siamo noi stessi ad infliggerci.
Per di più questa auto-punizione, a differenza di una punizione che eventualmente ci può essere inflitta dall'esterno, non ha un termine ben preciso: in altre parole non c'è una pena da scontare dopo di che si è espiata la propria colpa e si ritorna "liberi". Con il "senso di colpa" le cose vanno diversamente: paradossalmente proprio perché un'auto-punizione sembra apparentemente più facile da sopportare di una punizione che proviene dall'esterno, l'individuo che se la infligge sente, in un certo senso, di "averla fatta franca" e quindi si sente ancora più colpevole in una spirale che si alimenta da sé e lo porta a livelli di sofferenza sempre più acuti.
Molte delle depressioni che oggigiorno costituiscono il disturbo psichico più frequente che uno psicoanalista può diagnosticare nei suoi pazienti, allorché vengono analizzate adeguatamente possono rivelarsi come forme contorte di auto-punizione che certi individui, a livello inconscio, si auto-infliggono perché si "sentono in colpa".
Per di più il "senso di colpa" non è mai commisurato alla gravità dell'errore reale che l'individuo può aver commesso: alcuni possono sentirsi in colpa verso i propri figli nonostante, ad un esame obiettivo, si rivelino essere dei genitori esemplari mentre, al contrario, il più pericoloso dei serialkiller può non provare alcun rimorso nei confronti del male che ha procurato alle sue malcapitate vittime.
È facile intuire come una religiosità vissuta in modo punitivo e persecutorio possa alimentare i "sensi di colpa". A questo proposito non è superfluo notare come nella religiosità cristiana l'idea di un Dio amorevole e disponibile a perdonare le nostre manchevolezze è andata via via sostituendosi a quella di un Dio più arcaico, severo, minaccioso ed intransigente [sottolineatura mia]. Tuttavia, al nostro interno, in quell'istanza psichica che noi psicoanalisti chiamiamo Super-Io e che corrisponderebbe, grosso modo, alla nostra coscienza morale, i divieti ed i rimproveri per le nostre inadeguatezze possono continuare a farsi sentire.
Si deve invece partire dall'ammissione dell'imperfezione della nostra natura umana: in questa nuova luce la distanza che separa i nostri reali traguardi da quelle che sono le nostre ambizioni più o meno elevate cessa di essere un fattore patogeno. Non è perciò infrequente osservare che spesso taluni individui soffrono psichicamente perché le mete che si sono prefisse sono troppo elevate e quindi possono sentirsi indegni quando non riescono a raggiungerle. Allorché gli obiettivi che si prefiggeranno saranno più commisurati alle loro reali capacità il dispiacere per le loro imperfezioni sarà destinato ad attenuarsi fino a scomparire del tutto.
Da questo punto di vista, perciò, gli psicoanalisti e gli uomini di chiesa possono trovarsi a svolgere, ognuno per la parte che gli compete, un compito analogo che consiste nel mitigare la severità di una religiosità vissuta in modo estremamente intransigente e punitivo e, parallelamente, attenuare i "sensi di colpa" per quelli che possono essere ritenuti i propri errori ed i propri fallimenti.
Proprio in linea con queste considerazioni, infatti, non è un caso che la psicoterapia e la psicoanalisi siano state spesso considerate come una forma moderna e secolarizzata di "confessione". Naturalmente un paragone del genere, se preso alla lettera, non può essere che respinto dal momento che trascura le singole peculiarità sia del sacramento della confessione che degli stessi trattamenti psicoterapeutici. Tuttavia, se si esclude che possa esistere una sia pur parziale sovrapponibilità dei due distinti fenomeni e con le dovute cautele che un paragone del genere obbligatoriamente richiede, non si può non riconoscere che può sussistere una certa analogia tra questi due distinti approcci che, pur nella loro irriducibile diversità, sembrano perseguire il medesimo obiettivo di riconciliare l'individuo con Dio, in un caso, e con la propria coscienza nell'altro.
Fin qui abbiamo parlato soprattutto dei rapporti tra psicoanalisi e religione focalizzando il nostro discorso sul ruolo patogeno che una religiosità mal vissuta può svolgere alimentando ed esasperando i "sensi di colpa" che possono accompagnare l'esistenza dell'individuo e precipitarlo nella sofferenza psichica. Abbiamo già ricordato che storicamente fu questo il primo terreno di incontro (e, talvolta, di scontro!) tra la religione e la psicoanalisi. Ma le considerazioni fatte a proposito di certe analogie tra "confessione cristiana" e "confessione psicoterapeutica" ci portano ora direttamente a discutere di un altro importantissimo aspetto di questo rapporto che, questa volta, ha a che fare con la terapia.
È un fatto che sia la religione che la psicoanalisi come terapia sottendano, pur con le loro irriducibili differenze, visioni del mondo che sono improntate alla "speranza" ed alla "salvezza". Dal punto di vista della religione questo significa che il percorso "salvifico" che essa ci prospetta si alimenta e si regge su sentimenti di fiducia e speranza riguardo al fatto che la "salvezza della nostra anima" sia effettivamente possibile. Se così non fosse noi cadremmo in preda alla disperazione (che, letteralmente, è perdita di ogni speranza) e la religione cristiana, non a caso, considera il sentimento nichilistico di assenza di prospettive future come contrario alla "grazia".
Orbene, fatte le debite differenze, la psicoanalisi come terapia segue anche in questo caso, come si diceva prima a proposito della confessione, un percorso che presenta notevoli analogie con questa visione del mondo improntata a speranza e fiducia.
Non è un caso, per esempio, che la psicoanalisi come terapia sia nata in contrapposizione a teorie scientifiche che sostenevano il peso cruciale dei fattori ereditari e genetici nella genesi delle malattie mentali. Queste teorie oggi godono di un rinnovato credito scientifico a dispetto di una psicoanalisi che invece attualmente sembra scontrarsi con manifestazioni di scetticismo sempre più crescenti.
Oggi, più di ieri, non è infrequente per chi svolge la mia professione sentirsi rivolgere dalla persona a cui abbiamo appena consigliato di effettuare un lavoro di "scavo psicologico" su sé stesso e sui suoi problemi per venire a capo delle sue difficoltà la solita domanda: "Ma serve davvero? Non è che questo è il mio carattere, la mia personalità, il mio modo di essere e perciò non c'è niente da fare? Chi nasce tondo non muore quadro!".
Queste forti perplessità, che in gergo tecnico si chiamano "resistenze", trovano nelle teorie scientifiche più biologistiche, che enfatizzano il peso dell'ereditarietà e dei fattori genetici, un forte alimento ed una base razionale per sorreggersi ulteriormente.
Sia ben chiaro! Nessuno vuol qui misconoscere il ruolo dell'ereditarietà di certe caratteristiche psicologiche o il peso dei fattori genetici nello sviluppo di certe patologie mentali. Una simile negazione del peso di questi fattori non è stata mai sostenuta, nemmeno agli albori della scienza psicoanalitica, più di un secolo fa! Ma enfatizzare più del necessario il peso dei fattori ereditari e genetici in psicologia conduce irrimediabilmente all'idea di inguaribilità delle malattie mentali e di immodificabilità del comportamento umano (non solo delle patologie più gravi ma anche dei più lievi disturbi di personalità o difetti del carattere) condannando così tutti i nostri sforzi ad una sorta di "nichilismo terapeutico" in cui nulla vale più la pena di essere tentato dal momento che tutto è ritenuto inutile.
Qui la "disperazione terapeutica" (letteralmente "mancanza di speranza" terapeutica), fatte le dovute proporzioni e differenze, si pone sullo stesso piano della mancanza di fede nelle prospettive di salvezza indicate dalla religione. Certo, in quest'ultimo caso si parla di salvezza dell'anima! Ma, anche se non è la stessa cosa, qui stiamo parlando di guarigione di "malattie dello spirito" così come sono i disturbi psicologici.
Senza essere facilmente ottimisti o utopistici, basti qui ricordare come da un diverso atteggiamento terapeutico verso questi disturbi possano scaturire esiti differenti. Non è infrequente, così, osservare come anche le più gravi patologie mentali, con una base eziologica sicuramente organica, possano avvantaggiarsi di un atteggiamento terapeutico improntato alla valorizzazione di quelle pur minime potenzialità residue che, anche nei casi più gravi, risultano conservate. Certamente questi sono casi che non guariranno, nel senso letterale del termine; ma sono suscettibili di migliorare notevolmente e, anche se non raggiungeranno quella che comunemente può essere definita come "normalità psichica", rispetto al grado di gravità che presentavano all'inizio potranno trovare contenute alcune delle loro difficoltà più rilevanti.
Al contrario, l'idea che non vi sia nulla da fare può far peggiorare notevolmente la situazione anche nel caso di un semplice e lieve disturbo del carattere. La depressione, che sembra oggi aver sostituito e superato per incidenza e diffusione quasi tutte le patologie mentali del passato, è appunto un disturbo psichico che può essere curato in molti modi (nel senso che si avvantaggia di un approccio terapeutico multidisciplinare). Ma, al di là di quello che sarà il trattamento prevalente, rimane il fatto indiscutibile che al depresso deve essere restituita fiducia nel futuro, fiducia nelle proprie capacità, certezza di riuscire a superare le difficoltà del momento presente ecc. e si tratta di sentimenti che possono riattivarsi solo allorché si ripristina nell'individuo la possibilità di ricominciare a "sperare".
La "speranza" diviene quindi il vettore su cui possono poggiare tutti gli altri interventi terapeutici: se viene a mancare quella, questi ultimi possono risultare inutili; laddove questa capacità di "sperare" in un futuro migliore risulta essere consolidata, invece, tutti gli altri interventi agevoleranno il percorso verso il miglioramento.
La "speranza", che sappiamo quale ruolo cruciale svolga all'interno della religione, risulta essere un sentimento altrettanto indispensabile per ogni progresso terapeutico nel campo delle malattie dello spirito quali sono appunto i disturbi psicologici. È appunto per questo che una solida "mentalità religiosa" può risultare di notevole aiuto nel cooperare in questa difficile impresa di recupero delle proprie potenzialità minata da disturbi depressivi.
Deve trattarsi, ovviamente, di una religiosità matura e non dogmatica [paradossalmente questa affermazione è poco ovvia, infatti: cosa significa?]. Che presuppone la superiorità dello "spirito" sulla "materia" (a cui facilmente può ricollegarsi l'idea che la psiche possa avere una certa supremazia sul corpo).
Volendo ora tirare le fila di quanto detto fino ad ora prima di avviarci verso le conclusioni, è opportuno innanzitutto ribadire quanto abbiamo detto all'inizio: di fronte alla religione, la psicoanalisi non deve (e non può) entrare nel merito del contenuto di verità dei fenomeni religiosi. Non è questo il suo compito.
Ciò che le interessa è lo studio e la conoscenza della religiosità dal punto di vista strettamente psicologico, dal momento che questa è un'esperienza psicologica e non potrebbe essere diversamente.
Più specificamente, dal punto di vista psicoanalitico, ci si può chiedere, ad esempio, se la "religiosità" sia un fattore di promozione o di ostacolo del benessere psicologico di un individuo.
Se, allora, volessimo ora tentare di rispondere, nelle conclusioni di questo nostro discorso, a questo quesito specifico non potremmo fare a meno di rilevare, da principio, che una certa forma di "religiosità", oltre ad essere di ostacolo al benessere psicologico, funge addirittura da fattore patogeno in certi casi, alimentando il "senso di colpa" ed i disturbi psicologici che a questo possono ricollegarsi.
In questo caso ci stiamo riferendo, ovviamente, ad una "religiosità" arcaica e primitiva o, se si preferisce, infantile ed immatura, dove l'adesione a certe norme di vita o a certi principi non viene fatta per autentica convinzione ma esclusivamente per paura di un eventuale "castigo".
Una siffatta forma di religiosità, oltre a diventare fonte di sofferenza psichica per l'individuo a causa dello sviluppo del "senso dì colpa" e del bisogno auto-punitivo che da questo ne deriva, può altresì diventare la base per lo sviluppo di un vero e proprio "atteggiamento persecutorio" verso chi non si attiene con lo stesso severo rigore agli stessi principi. In altre parole, questa forma di religiosità è quella improntata all'intolleranza: intolleranza sia verso sé stessi per le più piccole imperfezioni sia verso gli altri che non si adeguano altrettanto dogmaticamente alle stesse norme di vita.
Al contrario, una "religiosità" matura e consapevole, basata su scelte di vita cui ci si attiene non per paura del castigo ma per reale convinzione, oltre a favorire il benessere psicologico, può esercitare addirittura una vera e propria azione terapeutica allorché aiuta l'individuo in difficoltà a continuare a sperare e ad avere fiducia in un futuro più roseo e migliore, diventando la base per uno sviluppo armonico della stessa integrità dell'Io. Questa "religiosità" è, al contrario dell'altra, improntata alla tolleranza, al perdono e all'amore e, così come mitiga i bisogni di auto-punizione verso sé stessi, è incline a tollerare anche negli altri la possibilità che si possa sbagliare ed essere colti in fallo. È una "religiosità", quindi, che non resta intransigentemente chiusa al confronto con l'altro ma è aperta al dialogo: che, in linguaggio religioso, si può anche definire "ecumenica", laddove, in termini psicoanalitici, rileviamo che è flessibile, aperta, non-rigida ecc.
Si tratta di valori che sono tutti presenti nel messaggio evangelico cristiano ("chi è senza peccato scagli la prima pietra!") ma che, talvolta, così come è tristemente accaduto nella stessa storia della chiesa, anche nell'esperienza del singolo credente possono ri-precipitare nell'oscurantismo e la contrapposizione tra i due diversi modi di essere "religiosi" che abbiamo descritto può ben essere esemplificata facendo riferimento alla spietatezza dell'inquisitore Torquemada, da un lato, e all'umiltà di San Francesco, dall'altra.
Non è allora infrequente, nel caso di trattamenti psicoterapeutici o psicoanalitici di persone religiose, assistere, parallelamente al recupero del benessere psicologico e all'attenuazione dei disturbi per cui avevano chiesto aiuto, ad una maturazione "evolutiva" del loro stesso modo di porsi nei confronti dei valori religiosi, da un'iniziale forma di adesione "dogmatica" e rigida allo sviluppo di un sentimento "religioso" vissuto in modo sereno, autenticamente cristiano, improntato all'amore.
È questo il caso in cui si ha la netta sensazione che la psicoanalisi e la religione si trovino a percorrere strade parallele che, anche se rimangono, come è giusto che sia, distinte e separate per quanto attiene alle loro diverse e specifiche finalità, nondimeno sembra che, in un punto lontano dell'orizzonte, tendano a sovrapporsi: un punto vicino all'infinito, là dove sembra che riconciliarsi con sé stessi e riconciliarsi con Dio siano, in sostanza, una cosa sola!
Tona alla Pagina "Conferenze"